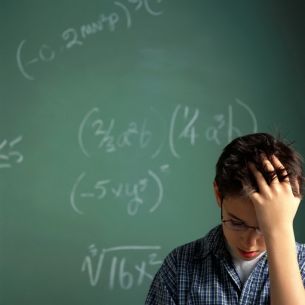Provincia, al voto (in pochi) tra i soliti paradossi italiani
 La politica è veramente il palcoscenico dei paradossi: una specie di camera fatta di specchi, in cui tutto ciò che, nel mondo normale, sarebbe puro delirio, viene presentato come fosse la cosa più normale del mondo. E, badate, non mi riferisco alle esilaranti bissabobe dei politicanti romani, che un giorno danno dello scemo a uno e, il giorno dopo, lo copiano pari pari: parlo di noi, orobi mesopotamici, stirpe di baghèt e di taragna, gente pratica e laboriosa. Perché sabato scorso, 2.843 bergamaschi, tra sindaci e consiglieri comunali, sono andati a votare per un’assise che non esiste più, almeno nelle parole felpate e false della politica, vale a dire il Consiglio Provinciale. Quattro liste, quarantanove candidati, sedici eletti. Nel più abissale ed assoluto disinteresse dei cittadini. Neanche un plissé sull’appassionante agone politico: nemmeno un bergamasco che abbia mangiato di magro o si sia astenuto dai commerci sessuali, in attesa del verdetto dell’urna. Anche perché dei destini di un consiglio in cui gli amministratori si votano tra loro, non si capisce poi per fare cosa, davvero pare impossibile che a qualcuno possa importare.
La politica è veramente il palcoscenico dei paradossi: una specie di camera fatta di specchi, in cui tutto ciò che, nel mondo normale, sarebbe puro delirio, viene presentato come fosse la cosa più normale del mondo. E, badate, non mi riferisco alle esilaranti bissabobe dei politicanti romani, che un giorno danno dello scemo a uno e, il giorno dopo, lo copiano pari pari: parlo di noi, orobi mesopotamici, stirpe di baghèt e di taragna, gente pratica e laboriosa. Perché sabato scorso, 2.843 bergamaschi, tra sindaci e consiglieri comunali, sono andati a votare per un’assise che non esiste più, almeno nelle parole felpate e false della politica, vale a dire il Consiglio Provinciale. Quattro liste, quarantanove candidati, sedici eletti. Nel più abissale ed assoluto disinteresse dei cittadini. Neanche un plissé sull’appassionante agone politico: nemmeno un bergamasco che abbia mangiato di magro o si sia astenuto dai commerci sessuali, in attesa del verdetto dell’urna. Anche perché dei destini di un consiglio in cui gli amministratori si votano tra loro, non si capisce poi per fare cosa, davvero pare impossibile che a qualcuno possa importare.
Prova ne sia che perfino tra i pubblici amministratori, che dovrebbero, come si dice, dare il buon esempio, c’è stata una significativa astensione: il 36%, superiore del 9% rispetto alla precedente tornata del 2014. Insomma, neppure ai diretti interessati interessa l’elezione di questo comitato di sbaraccamento: di questo plotone di psicopompi il cui unico vero ruolo parrebbe essere di facilitare il trapasso della defunta provincia ai campi elisi. E, allora, come direbbe Beppo Novello, perché? Per quale ragione eleggere un consiglio che non dovrebbe nemmeno esistere, che conta poco o niente e che nessuno si fila di striscio? Capirei se si trattasse del solito scopo umanitario, se ci fossero di mezzo le palanche: uno occupa la sua cadrega e si porta a casa un gruzzoletto solo per scaldarla. Ma qui non ci si guadagna mezza lira frusta. Manca, se mi passate il termine, il movente. Posso capire che a qualcuno faccia gola l’essere eletto per l’elezione in sé: ci sono quelli che si sbattono per essere membri di un consiglio d’istituto o presidenti di un’assemblea condominiale, e con Narciso non si scherza. Ma il legislatore che interesse avrebbe avuto nel mantenere questo lemure di elezione, questo fantasma di consiglio?
No, qui c’è qualcosa di più profondo, che risale alla ritrosia italica verso le semplificazioni: da noi, ogni semplificazione complica vieppiù le cose, inevitabilmente. C’è una specie di entropia mentale: un caos assistito, nelle menti dei nomoteti: basta sentire parlare di commissioni, comitati, assemblee, tavoli, workshop, consigli, che nelle menti dei politici si accende una lampadina da 10 candele. Che poi, diciamocelo, questa abolizione delle province non ci è andata giù fin dall’inizio. Le Province, poverine, non facevano male a nessuno: sono le Regioni, semmai, che andavano eliminate, perché sono un verminaio mangiasoldi. Le Province, da secoli, sono una dimensione perfetta per amministrare agevolmente un territorio: abbastanza grandi da porsi questioni progettuali di un certo respiro e abbastanza piccole da tener presente le istanze di tutti. Una regione come la Lombardia, invece, è un carrozzone colossale, che distribuisce denaro a vanvera e che, per dover decidere tutto, decide poco o nulla: una specie di Stato intermedio, che dello Stato centrale mantiene i peggiori difetti. Andrebbe eliminata, lo dico senza remore: e, se non fosse una miniera di incarichi, di poltrone, di consulenze e di sprechi, su cui i partiti campano in concorde baldoria, probabilmente, l’avrebbero già mandata in soffitta, insieme a tutti i dipartimenti napoleonici e ai podestà del Ventennio.
Invece, ci tocca di mantenerla, questa parodia di decentramento, mentre le Province fanno elezioni del tutto ininfluenti, tra liste che nessuno conosce, per fare scelte che nessuno avallerà. E’l’Italia, gentili lettori: un’elezione non si nega a nessuno, in questa specie di carnevale di matti. Il paradosso finale, la definitiva presa per il culo, è che, in questa pletora di soviet, in questa jungla di commissioni, comitati e consigli, l’unica cosa che manca per davvero è qualcuno che, alla fine, decida e si prenda la responsabilità delle decisioni. Uno che dica: si fa così e cosà e, se non funziona, la decisione è mia e mia la colpa. Ma, forse, sarebbe chiedere un po’ troppo ad un popolo di cagadubbi come il nostro, che cancella le Province e poi le mantiene in vita a stipendio zero e a potere decisionale zero meno. Ma va bene così: se non altro ci sarà qualcuno che potrà dire di aver vinto, qualche volta, da qualche parte. In bocca al lupo, dunque, ai sedici neoconsiglieri, chiunque essi siano: qualunque cosa faranno, auguro loro di farla bene, anche se, in fondo, mi piacerebbe capire almeno di cosa si tratta. Una mia amica che fa politica mi ha promesso di spiegarmelo: io aspetto fiducioso.