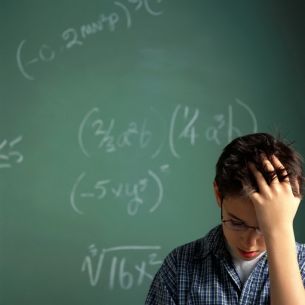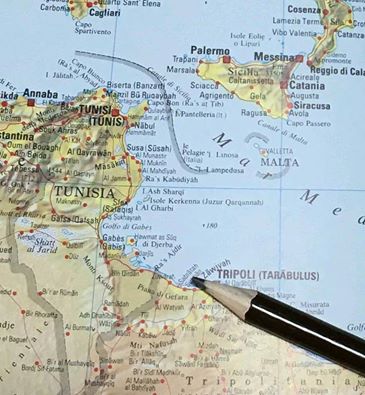Borsa, Ubi banca e la quotazione tra giudizi e pregiudizi
Sulle teorie dell’asimmetria informativa sono stati vinti dei premi Nobel per l’economia, ma non si è ancora riusciti a decifrarne il mistero. Che è poi la base del mercato e della Borsa, il mercato per eccellenza. Da una parte c’è un venditore che sa molto dell’azienda, ma magari non sa i motivi per cui dall’esterno è interessante e appetibile, dall’altra c’è un acquirente che non sa tutto dell’azienda, ma sa qualcos’altro. A complicare il tutto è il fatto che non si sa mai esattamente cosa sia vero e falso, cosa sia una convinzione giusta o sbagliata, e cosa magari sia una falsificazione. Senza scendere nel filosofico, la settimana nera che ha appena passato Ubi, con cinque sedute consecutive tutte in forte ribasso (lunedì meno 2,7%, martedì meno 2,6%, mercoledì meno 1,7%, giovedì meno 1,6% e venerdì meno 4,4%), al di là delle tensioni borsistiche generali, e in particolare sul settore creditizio, è un caso particolare di assimetria informativa, dove il mercato crede di sapere qualcosa, che però non è detto accada.
 Il fattore temuto è il salvataggio di qualche banca più o meno fragile con il rischio che Ubi finisca invischiata in situazioni problematiche ed onerose. Il cd Victor Massiah ha sempre affermato che non intende fare alcuna operazione che non produca valore per Ubi, ma questo non basta più a tranquillizzare un mercato stressato e confuso da messaggi contrastanti su questa e su altre vicende. Ormai da due anni Ubi per la sua solidità patrimoniale viene regolarmente invocata come cavaliere bianco per ogni banca in difficoltà. Nella convinzione che ogni matrimonio proposto non farebbe che indebolire Ubi, il titolo che a inizio anno valeva 6,15 euro è rotolato fino a 2,17 euro venerdì 16 settembre, una performance che non si giustificherebbe di fronte a un bilancio patrimonialmente solido, una gestione operativa in attivo, una costante distribuzione di dividendo, una situazione dei crediti deteriorati sotto controllo e i costi già contabilizzati per il piano industriale che promette risparmi e sinergie. Insomma, in Borsa c’è l’idea diffusa che ci debba essere qualcos’altro che sta maturando e non è positiva.
Il fattore temuto è il salvataggio di qualche banca più o meno fragile con il rischio che Ubi finisca invischiata in situazioni problematiche ed onerose. Il cd Victor Massiah ha sempre affermato che non intende fare alcuna operazione che non produca valore per Ubi, ma questo non basta più a tranquillizzare un mercato stressato e confuso da messaggi contrastanti su questa e su altre vicende. Ormai da due anni Ubi per la sua solidità patrimoniale viene regolarmente invocata come cavaliere bianco per ogni banca in difficoltà. Nella convinzione che ogni matrimonio proposto non farebbe che indebolire Ubi, il titolo che a inizio anno valeva 6,15 euro è rotolato fino a 2,17 euro venerdì 16 settembre, una performance che non si giustificherebbe di fronte a un bilancio patrimonialmente solido, una gestione operativa in attivo, una costante distribuzione di dividendo, una situazione dei crediti deteriorati sotto controllo e i costi già contabilizzati per il piano industriale che promette risparmi e sinergie. Insomma, in Borsa c’è l’idea diffusa che ci debba essere qualcos’altro che sta maturando e non è positiva.
Il mercato però è fatto da chi sa, da chi non sa e da chi crede di sapere. Se non ci fosse questa asimettria nessuno del resto comprerebbe o venderebbe e la Borsa avrebbe finito di esistere. Quello che per Ubi, in questi giorni, viene creduto vero anche se non si è ancora concretizzato e non è detto che si concretizzi è in particolare un intervento nell’acquisto delle quattro nuove “good bank”, ovvero la versione “risoluta” di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. In realtà l’interesse è stato più volte smentito in passato, con il ritornello che non c’è aperto nessun dossier, ma quando il mercato si convince di qualcosa è difficile fargli cambiare idea, anche perché a posteriori molte volte si è scoperto che alla fine ha avuto ragione. Per questa ragione, se non interverranno nuovi elementi che sgombrino definitivamente il campo dalle ipotesi, ovvero che Ubi rompa gli indugi o che le banche obiettivo trovino altri acquirenti – dato che anche le smentite più efficaci, in questa fase, lasciano il tempo che trovano -, si preannuncia una “nuttata” borsistica almeno fino a mese quando si chiuderà il termine per le manifestazioni d’interesse per le quattro banche e si capirà (forse) chi la sapeva veramente lunga e chi si è preso un abbaglio.
Al momento però si continua a restare nel campo di ipotesi che presentano inoltre tanti nodi da sciogliere. Le quattro good bank nascono infatti senza sofferenze, rimaste nel vecchio istituto, ma l’eredità della precedente gestione non è ancora del tutto chiara e sul piano operativo i primi mesi, seppure con tendenza al miglioramento, sono comunque in perdita. Non si conoscono poi i costi della necessaria ristrutturazione, oltre che dell’integrazione. E non si conosce nemmeno il prezzo d’acquisto, al di là del fatto che sarà sicuramente inferiore agli 1,6 miliardi del finanziamento erogato a novembre dal sistema bancario che auspicherebbe di poterli recuperare nella maniera meno parziale possibile. Sulla base di un acquisto a mezzo miliardo, gli analisti di Equita Sim hanno calcolato che con l’operazione, a perimetro invariato, l’indice patrimoniale Cet1 di Ubi scenderebbe da 11,4% a 9,1%, un livello che renderebbe inevitabile un aumento di capitale che, dato l’andamento della quotazione, non sarebbe molto gradito al mercato. La situazione sarebbe ovviamente meno pesante se l’acquisto fosse limitato a solo alcune (Cariferrara?) delle quattro banche. Ma le incognite e i dubbi che l’operazione apre, soprattutto con il sospetto che nonostante tutto l’acquisizione venga eterodiretta se non imposta, scavalcando l’istituto, fa diffidare il mercato, che nelle sue convinzioni non sta nemmeno valutando se queste operazioni hanno prospettive industriali, che a certi costi diventano interessanti. Vale più il pregiudizio del giudizio. E nel frattempo la quotazione si muove di conseguenza.