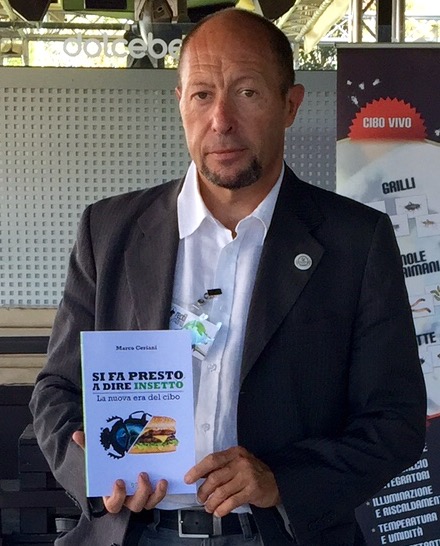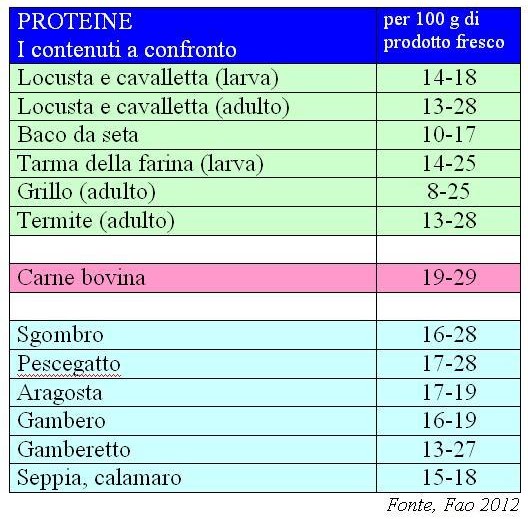Bergamo, i Vip si raccontano a frigo aperto
La versione contemporanea del “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei” è la fotografia del frigorifero. Sulle quantità, il tipo di alimenti, la disposizione dei prodotti e l’organizzazione c’è chi ha tracciato profili psicologici e mappe sociologiche (anche la Bbc ci ha costruito un’inchiesta) o creato percorsi artistici. È del resto piuttosto immediato farsi un’idea dello stile di vita e dei gusti di una persona e di una famiglia sbirciando tra gli scomparti e se riflettiamo su cosa c’è nei nostri potremo altrettanto facilmente renderci conto di quale piega abbia preso la nostra esistenza in determinato momento. Un gioco che quattro personaggi della nostra Bergamo hanno accettato di fare con simpatia, raccontando se stessi attraverso quella bottiglia tenuta in fresco, l’ingrediente irrinunciabile o la tentazione golosa.
La foodblogger
Vatinee, «all’interno due anime, una thailandese e una bergamasca»
Per una foodblogger, il frigorifero è in pratica uno strumento di lavoro. Tanto più se è tra le promotrici di una community come Bloggalline e la responsabile di un portale da un 1,3 milioni di contatti unici al mese e 3 milioni di pagine visitate, iFood, nato solo un anno fa dalla volontà di fare rete delle stesse blogger e già capace di proporsi come «la risposta dal basso a Giallo Zafferano». Lei è Vatinee Suvimol, thailandese cresciuta tra Singapore, Germania e Italia, approdata a Bergamo nel 2000, dove ha messo su famiglia e il suo studio di avvocato.
Abita a Colognola ed ha voluto un frigorifero non solo perfettamente inserito nella moderna cucina, ma anche efficiente e funzionale. All’interno due anime. «Io mangio quasi sempre thailandese – racconta –, è strano perché ho vissuto in Thailandia solo fino a sei anni, ma quando torno a casa dal lavoro, nel tardo pomeriggio, mi preparo quasi sempre un piatto orientale, anche una semplice zuppetta con noodle. Sarà il richiamo delle radici, non so, comunque mi fa stare bene». E così nel cestello delle verdure non manca mai il lemongrass, uno degli ingredienti che hanno reso famose le sue ricette. «È la citronella – spiega -. Ha uno stelo simile al porro, si affetta la parte bianca e si utilizza per il soffritto, ad esempio. Ha un sapore agrumato, vicino anche allo zenzero, quel che basta per dare il tocco thailandese che mi serve». Nel frigo si trovano anche melanzane thailandesi, differenti per forma e gusto da quelle occidentali, cavolo cinese, salsa di soia o di pesce e altri prodotti esotici, che non fatica a trovare in città, al negozio di via Angelo Maj, per la precisione.
Il resto della famiglia preferisce i sapori nostrani. «Mia figlia Sofia, sette anni, è thailandese di aspetto, ma “bergamasca” in fatto di gusti, mangerebbe solo polenta, cotoletta, spaghetti – svela – e mio marito ha sempre assaggiato tutto ma solo in Thailandia, salvo poi proporsi come perfetto intenditore di quella cucina quando abbiamo ospiti a cena». «Non mangiamo carne di maiale per scelta alimentare – prosegue -, in frigo ci sono quindi pollo, tacchino e manzo, verdure. Il pesce preferisco cucinarlo appena comprato». Cosa manca? «Spesso e volentieri il latte. Beviamo latte di soia, ma quello vaccino serve in molte ricette di dolci, che sono tra quelle più frequenti e apprezzate del mio blog (A Thai Pianist ndr.) e così mi ritrovo il più delle volte senza». Il prodotto che invece finisce con l’essere dimenticato è il coriandolo. «Mi piace tantissimo, ma ne basta poco in ogni piatto e così il mazzetto resta a lungo in fondo al cassetto del frigo».
 Da brava blogger, inoltre, Vaty viaggia, scopre, gusta e si porta a casa tante chicche gastronomiche. «Se la cucina thailandese è quella del cuore, non vuol dire che non apprezzi quella italiana, tutt’altro – precisa -. Mi vengono in mente un bel piatto di spaghetti alle vongole, un filetto o le tante specialità regionali». E il successo dei suoi piatti sta proprio nella contaminazione. «Talvolta sono ricette della tradizione thailandese riproposte con ingredienti italiani – evidenzia -, in altri casi prodotti e piatti tipici di quella italiana con un accento esotico, come l’incontro tra porcini e curry, apprezzato dalla rete, o i paccheri di Matera abbinati a uno spezzatino di vitello preparato con curry e latte di cocco, con il quale ho vinto un contest nazionale. L’ultima tendenza, sul versante dei dolci è il tè macha, un tè giapponese che dà un colore verde intenso alle preparazioni».
Da brava blogger, inoltre, Vaty viaggia, scopre, gusta e si porta a casa tante chicche gastronomiche. «Se la cucina thailandese è quella del cuore, non vuol dire che non apprezzi quella italiana, tutt’altro – precisa -. Mi vengono in mente un bel piatto di spaghetti alle vongole, un filetto o le tante specialità regionali». E il successo dei suoi piatti sta proprio nella contaminazione. «Talvolta sono ricette della tradizione thailandese riproposte con ingredienti italiani – evidenzia -, in altri casi prodotti e piatti tipici di quella italiana con un accento esotico, come l’incontro tra porcini e curry, apprezzato dalla rete, o i paccheri di Matera abbinati a uno spezzatino di vitello preparato con curry e latte di cocco, con il quale ho vinto un contest nazionale. L’ultima tendenza, sul versante dei dolci è il tè macha, un tè giapponese che dà un colore verde intenso alle preparazioni».
Il calciatore
Bellini, «qualche sfizio c’è, birra e gelato su tutti»

Quanto al frigorifero, ha fatto un bel salto la bandiera dell’Atalanta Gianpaolo Bellini, un’intera carriera con la maglia nerazzurra e un commovente addio al calcio giocato, con tanto di rigore trasformato, nell’ultima partita al Comunale di quest’anno, contro l’Udinese. Nella sua vita da single il frigo era quasi un optional. Ci metteva acqua, birra e qualche piatto pronto surgelato, da riscaldare in caso di emergenza. «Stavo poco a casa e mangiare da solo non mi piace», ricorda.
Oggi invece, che è sposato con Cristina ed ha due bambini piccoli, due anni il primo, pochi mesi il secondo, nella sua casa di Mozzo di frigoriferi ne ha ben due «e sono sempre belli pieni – svela -. Soprattutto delle pappe e dei prodotti per i bambini, ma anche di tutto il resto. Preferiamo la carne al pesce, anche se il nostro primo bimbo ne è golosissimo e ci sta portando a consumarne di più. C’è la verdura, meno la frutta, che non amiamo molto. La spesa la facciamo insieme, mia moglie ed io, perché sono sempre carichi importanti».
I ritmi e le scelte sono quelli di una giovane famiglia che non ha molto tempo per cucinare, ma non rinuncia al gusto e alla qualità. «Il congelatore è sempre ben fornito, però i piatti pronti non ci sono più, se non qualche busta di risotto – dice il calciatore -. Facciamo scorta di carne e la surgeliamo perché è più comodo e ci permette di organizzarci meglio. Prepariamo piatti semplici, ma cerchiamo sempre di assaggiare anche qualcosa di particolare».
Come la mette uno sportivo con le tentazioni? «Qualche extra c’è – ammette Bellini – dei dolcetti, cioccolato, qualche bibita gassata e nel freezer sempre il gelato, anche d’inverno. Mi concedo un piccolo sfizio prima di andare a letto, come anche un bicchiere di birra la sera, la preferisco al vino. In fresco comunque teniamo sempre una bottiglia di bollicine per quando abbiamo ospiti e stare a casa con gli amici ci piace». È goloso anche di formaggi, «una fetta a fine pasto ci scappa, anche perché dei parenti hanno un allevamento e ci riforniscono di prodotti nostrani». E c’è pure il fratello Gianmarco che porta avanti l’attività dei bisnonni al ristorante Ai Burattini di Adrara San Martino, inserito nella guida Osterie d’Italia di Slow Food: «Quando andiamo da lui – afferma – spazzoliamo sempre tutto, per il frigo di casa non avanza niente».
Piccole trasgressioni a parte, resta un atleta che con il cibo non ha mai esagerato. «Ho però ho capito solo attorno ai trent’anni quanto è importante l’alimentazione per essere in forma, avere energia e vivere meglio – riflette -. Bisognerebbe farlo da giovani, le prestazioni sarebbero migliori e i risultati più duraturi. Prima però non ci pensi e mangi senza farti troppe domande». Oggi il suo “credo” alimentare lo attinge da sua suocera: poco di tutto. «Servono equilibrio, moderazione e variare il più possibile perché ogni alimento ha proprietà diverse – sottolinea -. Ho anche imparato a bere molta acqua, dà una grande mano, anche a chi non è sportivo». E se lo dice l’ex capitano…
Il provveditore
Graziani, «quella volta in cui ci dimenticai le chiavi di casa…»
Non si illudano gli studenti bergamaschi. Nel frigorifero della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale – l’ex Provveditorato, per chi i banchi li ha lasciati già da qualche tempo – non ci sono scheletri. Patrizia Graziani rispetta i principi di quella corretta alimentazione che la scuola cerca di insegnare sin dalla più tenera età per favorire l’adozione di stili di vita consapevoli e salutari. Nel frigo di casa sua, a Mantova, ad occupare lo spazio maggiore sono verdure e frutta di stagione. «Ce n’è una varietà infinita – racconta -. In particolare gradisco le verdure cotte al vapore o grigliate che, da buona mantovana, condisco con Parmigiano Reggiano, senza olio. Poi c’è il pesce, che cucino alla griglia per lo più, e talvolta della pasta fredda. Non mangio carne, invece».
Semplicità non significa rinuncia: «Sono piatti che appagano il palato e poi qualche trasgressione ogni tanto ci sta». Quella che ci confessa, per soddisfare la voglia di dolce, è per la Coca Cola e le bibite gassate, anche se le sceglie “light” o “zero”. Ma la meglio ce l’ha il vino. «Mi piace accompagnare il pasto con un buon bicchiere – afferma -, in particolare amo i rossi piemontesi. In fresco invece tengo le bollicine della Franciacorta, che fanno sempre festa». E non dimentica il territorio. «Pur partendo da ingredienti spesso poveri, la cucina mantovana è molto ricca, tanto da essere detta “la cucina dei principi” – spiega -. I tortelli di zucca sono un emblema ed ho la fortuna di avere una mamma che li fa in casa. Sono però un piatto prevalentemente invernale, così come i cotechini e gli zamponi, che preparo per mio marito». Della Bergamasca apprezza i funghi, la polenta taragna e i formaggi: «Branzi, Taleggio e alcuni stracchini li compro a Bergamo perché sono particolari».
Coerente con i suoi gusti è il reparto surgelati. «Sono pochi – rivela Patrizia Graziani – e semplici, come gli spinaci, il misto di pesce per preparare il risotto o i gamberetti, che mi piace aggiungere alle insalate». Niente piatti già pronti, invece. «Anche se si ha poco tempo, è molto meglio una pasta in bianco fatta al momento con un po’ di Parmigiano – dice -. Se gli ingredienti sono di qualità il risultato è comunque ottimo». Attenta è anche la sua gestione delle scorte. «Ritengo lo spreco un peccato – rileva -. Cerco di misurare gli acquisti e di non lasciare scadere i prodotti, il compito, del resto, è facilitato dal fatto che, con mia figlia che ha ormai preso la sua strada, siamo solo in due in casa».
«Non sono tra quelle persone che con il cibo hanno un rapporto simbiotico – riflette ancora -. Non mangio in grandi quantità e infatti sono molto magra, ma apprezzo i piaceri della tavola, la qualità dei prodotti, scoprire sapori particolari e percorsi». Quando si tratta di spezzare la tensione, però, sgranocchiare qualcosa aiuta e si lancia sui pomodorini Pachino, «sono gustosi ed hanno l’effetto delle ciliegie, uno tira l’altro». E qualche defaillance domestica l’ha avuta anche lei. «È ormai diventata una barzelletta di famiglia quella volta che nel frigorifero ci ho dimenticato le chiavi di casa: così almeno le ho ritrovate, sarebbe stato peggio averle perse», ricorda divertita.
Il cantante
Il Bepi, «è il frigo di un single che non sa cucinare e non ha voglia di lavare i piatti»

Ci mette poco Il Bepi a passare in rassegna il contenuto del suo frigo: affettati confezionati e piadine, formaggio, sempre per farcire la piadina, birra, vino bianco (ché quello rosso non va al fresco), frutta, della quale si dice molto goloso, e poi mozzarella, insalata e pomodori, le uniche verdure che trovano posto negli scomparti. «In verità ho visto esempi ben più desolanti», si smarca il cantautore e conduttore tv di Rovetta, al secolo Tiziano Incani, che del dialetto e delle radici ha fatto la sua cifra espressiva. «Il mio è il frigorifero di un single che non ama e non sa cucinare e che non ha nemmeno voglia di lavare troppi piatti, tanto meno padelle – spiega -. Se somiglia al Bepi? Direi nell’essenzialità, nella scelta di cibi semplici che non vuol dire di scarsa qualità e valore. Preferisco sfuggire invece al luogo comune del personaggio tutto “salàm de fèta zo” (il rito di affettare il salame intero ndr.): mi piacciono i salumi, ma anche le insalatone col tonno e non vado certo in crisi d’identità per questo».
Pur se gli capita spesso di mangiare fuori («soprattutto pizza o kebab»), non sono rare le occasioni in cui si gode, a orari umani, la sua cena ideale – a base di piadina o insaltona, appunto – felice di starsene da solo, «sul terrazzo nell’una o due sere di tutta l’estate in cui la temperatura a Rovetta concede di stare all’aperto». «Il vero dilemma della cena è se accompagnarla con il vino o la birra – confessa -. Dipende un po’ dall’umore, dalla giornata, dalle sensazioni, sono due piaceri diversi. Non sono di quelli che rifuggono l’acqua ai pasti – precisa -, non mi dispero se c’è, ma con una birretta è un’altra cosa». La sua preferenza nel tempo è passata dai sapori particolari delle rosse ad alta gradazione alle più fresche e leggere bionde tedesche o alle più amarognole e agrumate Ale. Quanto ai salumi, «quello che si trova più facilmente in frigo è lo speck – racconta -, sono amante di tutti i prodotti dell’Austria e del Tirolo, ad eccezione dei crauti. Poi c’è il prosciutto cotto, che va sempre bene se c’è qualcuno a cui offrire un boccone, e la coppa». «Forse non è proprio un’alimentazione sana – gli viene il dubbio -, ma in fondo alterno spesso con le insalatone», si rasserena.
Non è però goloso di dolci e sul cibo non ha un atteggiamento compulsivo. «Sono vanitoso quanto basta per frenarmi, non mi piace l’idea di vedermi grasso – dice Il Bepi -. Con l’alimentazione ho un rapporto garbato, non viscerale. Quando poi mi voglio viziare scelgo con cura locali dove mangiare e bere bene». Per quanto poco assortito, il suo frigo non è mai vuoto. «Il cibo è comunque conforto, consolazione – annota – e non mi va di tornare a casa, magari dopo una giornata impegnativa, e non trovare niente». Se le sue cene da single lo appagano, il problema di essere da solo in casa si manifesta con gli omaggi gastronomici che riceve. «A volte mi regalano vasetti di salsine sfiziose – evidenzia -, le utilizzo una volta o due, ma poi è inevitabile che vadano a male, servirebbero delle confezioni più piccole. È lo stesso motivo per cui non compro maionese o salsa tonnata. E poi ci sono i salumi. Se mi offrono una pancetta che faccio? La regalo a mia volta, anche se, per la verità, mi piacerebbe almeno assaggiarla».
Un’altra controindicazione dei suoi pasti casalinghi è che può capitare di “rilassarsi” un po’ troppo. «In una di quelle sere che avevo deciso di dedicare a me stesso – ricorda – ho fatto onore a un buon bianco. Proprio quella sera un vicino aveva scoperto chi fossi e deciso di farmi visita per conoscermi. Credetemi, ho cercato ogni modo per far sì che la conoscenza non si approfondisse in quella circostanza…».